Covid19, tra ansia e solitudine: prendi una pillola di filosofia
“Non sorge a tratti, nel più silenzioso isolamento, un vedere inaspettato?”
M. Buber
In questi giorni, la diffusione del virus SARS-CoV2 sulla nostra penisola sta creando una generale situazione di angoscia, cui si aggiunge la necessità di far fronte a una condizione nuova di diradamento dei rapporti interpersonali che espone ciascuno all’esperienza della solitudine.
L’angoscia e la solitudine non sono esperienze patologiche, sebbene in taluni casi possano diventarlo. Si tratta invece di esperienze umane fondamentali, con le quali ciascuno di noi nella propria vita si trova in un modo o nell’altro a fare i conti.
Da bambini, proviamo angoscia quando perdiamo i nostri riferimenti sicuri, che ci permettono di orientarci nel mondo; come accade quando, nella stanza, la luce viene spenta e il buio improvviso crea un ansioso spaesamento.
L’angoscia non è la paura, perché il suo oggetto è più indeterminato. Quando ho paura percepisco chiaramente una minaccia che incombe, la riconosco, ne vedo il pericolo, il cuore batte e il timore cresce. L’angoscia è diversa.
Come ci dice Eugenio Borgna, si tratta di “un’esperienza improvvisa, o continuata, di spaesamento e di inquietudine (di sventura imminente) che ha in sé qualcosa di in-determinato e di liberamente fluttuante” (2009, p.24).
In latino era angustia “strettezza”, dal verbo angere, ossia “stringere”, da cui deriva anche il termine anxia (ansia).
Strano momento questo nostro, in cui mentre il Covid19 minaccia di stringere il respiro a migliaia di persone, l’angoscia e l’ansia tengono tutti noi insieme “col fiato sospeso” e ci stringono in un senso di oppressione che provoca agitazione.
Per un verso, quest’angoscia di oggi non è come quella del bambino, poiché non riguarda soltanto il singolo individuo ma ha un anelito sociale. Ci sentiamo un po’ tutti coinvolti in un diffuso e medesimo stato d’animo.
Naturalmente però, ciascuno poi vive il proprio sentimento, con le sue peculiarità, determinate dalla propria biografia e dalla gestione della propria quotidianità famigliare e lavorativa. Chi siamo, il rapporto che abbiamo con noi stessi, con i nostri cari e in generale con quanto ci circonda non sono indifferenti al nostro modo di affrontare e di sentire la situazione presente.
L’emergenza ha sospeso alcuni punti di riferimento stabili delle nostre vite e ciò non può che creare ansia: se sono uno studente, ora dovrò riempire il tempo che prima dedicavo alla scuola in modo nuovo; se sono genitore, non servirà più che accompagni i bambini a scuola, ma dovrò imparare a gestire la loro presenza costante in casa; se sono un impiegato, bisognerà ch’io cominci a lavorare per l’azienda dalla mia abitazione senza più recarmi tutte le mattine in ufficio; se faccio l’insegnante, mi verrà chiesto di attrezzarmi per la didattica online, ecc.
Un ruolo importante è rivestito dalla cultura. Molte delle nostre abitudini quotidiane infatti – che ora sono state sospese dall’emergenza – sono abitudini culturalmente e socialmente indotte. Come ad esempio il bisogno rituale di aperitivi, apericene e cene oppure di recarci comodamente al centro commerciale per fare la spesa (del necessario e del superfluo), usufruendo anche di tutta una serie di servizi e di negozi. Così siamo abituati a fare la nostra parte di solleciti consumatori nella grande macchina del mercato.
Non c’è da stupirsi che molti facciano una gran fatica a riorganizzare la propria esistenza o che tentino maldestri tentativi di fuga da eventi imprevisti: siamo come bambini a cui hanno spento la luce nella stanza che ora sono costretti a imparare a muoversi anche al buio. Siamo s-paesati, letteralmente senza più il paese, il paesaggio e la casa cui eravamo abituati.
Il fatto che si tratti di un “mal comune” può forse un po’ rassicurarci, se non proprio costituire un “mezzo gaudio”. D’altra parte, l’angoscia ci mette in stretto rapporto con noi stessi e con la nostra interiorità: è un’esperienza che si vive soli.
C’è uno stretto rapporto tra angoscia e solitudine. Ognuno vive per se stesso questo senso di spaesamento e anzi qui si trova innanzitutto dinanzi a se stesso, come in nessun’altra circostanza.
Può forse consolarci il fatto che ciò non sia di per sé qualcosa di negativo. L’ansia e la solitudine possono infatti far emergere e riemergere possibilità nascoste e possibilità nuove che abbiano anche un significato creativo.
Perché ciò sia possibile, ovvero per dare modo all’angoscia di liberare potenzialità ed evitare che possa invece paralizzarci e soffocarci, è necessario imparare ad ascoltarla.
L’unico modo per farlo è smettere di cercare rassicurazione soltanto negli strumenti della ragione calcolante (la scienza). Leggere ossessivamente articoli e notizie che riportano dati e statistiche, non può sedare l’angoscia: al massimo può costituire un diversivo, ma più spesso rappresenta un incremento dell’ansietà.
Bisogna imparare il linguaggio del cuore. Lo sentite? Il cuore nei momenti di angoscia accelera il suo ritmo.
“Il linguaggio del cuore non è il linguaggio degli altri organi: è il linguaggio del silenzio” (Borgna, 2009, p.74).
Occorre fare silenzio intorno a sé e dentro di sé per ascoltare ciò che l’ansia e l’angoscia hanno da dirci. Se non lo facciamo il loro messaggio sarà passato invano e avremo perso una grande occasione per comprendere meglio noi stessi. Non solo, se non prestiamo orecchio ora, tuttavia l’inquietudine sepolta non sarà eliminata e non smetterà in futuro di bussare alla nostra porta, in maniera forse perfino più aggressiva.
La diminuzione delle relazioni interpersonali cui oggi siamo costretti, ci fornisce la possibilità di onorare il linguaggio del cuore. Non si tratta infatti semplicemente di una condizione coatta di parziale isolamento – ovvero di parziale interruzione di contatti sociali – ma di un momento nel quale possiamo operare la scelta di essere soli con noi stessi.
È una differenza tra obbligo e libertà.
Che cosa significa rendere l’isolamento una forma di solitudine?
Mentre l’isolamento ci chiude, potremmo dire con una metafora, la solitudine è una porta aperta. Oppure anche l’isolamento è sistolico (opprime), la solitudine è diastolica (fa respirare): il ritmo del cuore che nell’isolamento mi paralizza, nella solitudine finalmente mi parla.
La solitudine è innanzitutto una scelta che ha a che fare con i propri spazi: significa allontanarsi da situazioni e relazioni ma anche avvicinarsi a se stessi e alle cose essenziali e radicali che l’angoscia porta con sé.
Diceva Nietzsche che “là dove la solitudine finisce, inizia il mercato”: bene, dunque, laddove il gioco del mercato e del consumo si interrompa, ecco l’occasione per ritrovarci vicini a noi stessi.
Ritrovarci isolati è fare esperienza di un vuoto e molti di noi possono essere tentati di riempirlo in fretta con forme di svago ed esperienze effimere. Questo però significa soltanto subire passivamente l’allontanamento dagli altri e dal chiasso della società e dei media.
Se vogliamo fare un’esperienza di senso, occorre farsi vicini a sé e fare silenzio. Occorre tollerare il battito del cuore e prestarvi ascolto.
Cosa accade allora?
Accade che la nuova esperienza spaziale, per cui mi faccio vicino a me stesso, diventi anche un’esperienza temporale: qui trovo il mio tempo. Non il tempo dell’orologio, né il tempo del lavoro o del consumo: proprio il mio tempo.
La solitudine mi espone a domande sul mio passato, su ciò che esso rappresenta per mio presente. Gli eventi passati e ciò che sono stato, mi bloccano, mi opprimono o mi permettono di andare avanti? Domande sulla mia quotidianità e i suoi ritmi: essi rispecchiano davvero ciò che voglio per me, ciò di cui ho bisogno? Domande sul futuro, mio e dei miei cari, e così via.
Non è una scelta facile, la solitudine, “poiché l’uomo viene qui in contatto con le potenze e le tensioni del suo intimo, con le esigenze incalzanti della sua coscienza” (R. Guardini).
Tuttavia, abbiamo davvero alternative? Distrarci ci libererà da noi stessi? No.
Non ci libererà neppure da quell’interrogativo ultimo e radicale, dischiuso dall’angoscia e dalla solitudine. Se il tempo che abbiamo non è infinito, va da sé che avvicinarsi al proprio tempo sia anche esporsi alla domanda sulla morte e sul morire.
Viviamo un’epoca storica che, con ogni strumento e in ogni modo, tende a nascondere la morte, eliminandola dallo sguardo e dalla riflessione. La morte può essere mostrata solo quando sia spettacolarizzata, ossia data in pasto a qualche titolo di giornale o alle serie tv: un modo di mostrare la morte che non ce la rende più conosciuta, ma più lontana.
Il pericolo del contagio, l’angoscia di un nemico indeterminato e invisibile, ci espone inevitabilmente a questo pensiero che pur essendo costantemente negato e allontanato, non cessa però mai di abitare la nostra cultura e di sottendere alla nostra esistenza.
Leggiamo ovunque “M. aveva 80 anni: ucciso dal coronavirus”, “S. aveva solo 30 anni: nuova vittima del Covid19”, “Uno studio rivela che il Covid19 uccide più spesso la fascia d’età compresa tra i 45 e i 65 anni”.
Davvero crediamo di venire uccisi dal coronavirus?
In realtà, noi non moriamo perché ci ammaliamo bensì ci ammaliamo perché dobbiamo morire: la destinazione della vita umana è questa e il nostro tempo ci è dato come finito.
Abbiamo una grande opportunità oggi: quella di ritornare a sentire la nostra finitezza.
Solo ricordando che il tempo è limitato, potremo scoprirne l’enorme valore.
Il tempo è poco, ragazzi, per tutti. Perché sprecarlo in coda per acquistare l’ultimo I-phone o per scorrere le foto degli influencer su Instagram o per fare a botte allo stadio contro i tifosi della squadra di calcio avversaria? Perché perdersi nell’odio, anche online, oppure nel rancore nei confronti di qualcosa o di qualcuno? Perché temere di amare e di soffrire quando sono proprio ciò che ci fa capire di essere ancora vivi?
Isolati, sentiamo quanto fondamentale sia per noi l’essere-con-altri. Specialmente, quanto siano preziose le relazioni significative, gli affetti. Avvertiamo perfino quanto sia faticoso pensare alla nostra salute e non abbracciare e baciare qualcuno per un semplice saluto.
Ricordiamocela per il futuro questa esperienza di angoscia e di solitudine. Ricordiamola come un dono, quel tipo di dono che solo i momenti difficili sanno offrirci: il dono di comprendere ciò che nella vita vale davvero la pena.
“Perché le parole dell’anno passato appartengono al linguaggio dell’anno passato
E le parole dell’anno prossimo attendono un’altra voce”.
(Thomas Stearns Eliot)
Bibliogafia
Borgna E., Le figure dell’ansia, Feltrinelli, Milano, 2009.
Buber M., Il principio dialogico e altri scritti, San Paolo, Milano, 1993.
Guardini R., Libertà-grazia-destino, Morcelliana, Brescia, 1968.
Nietzsche F., Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 1989.
Autore:
Maddalena Bisollo
Direttrice Scuola Pragma Milano
www.scuolapragma.com

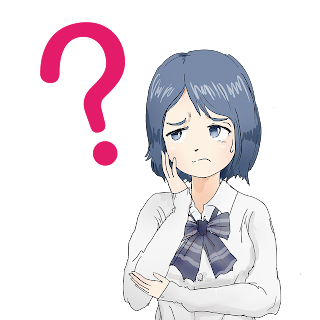
0 commenti